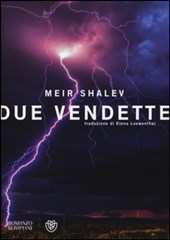
LibriDue vendette di Meir Shalev
di Mara Marantonio
L'inizio ha quel magico tocco di mistero in grado di catturare subito l’attenzione del lettore.
Breve prologo: la concitata comunicazione telefonica tra due uomini. Il primo, giovane, robusto, ma indeciso nel comportamento e nella parola, ebraico parlato in modo approssimativo; l’altro, tipo duro, capace di intuire ogni gesto del primo.
Cambio di prospettiva, alcune ore dopo, di notte. Un terzo uomo, Eitan, è impegnato nella meticolosa preparazione di un breve viaggio che culminerà in una vendetta, da consumarsi all’alba.
E’ ancora buio fuori quando egli lascia la propria casa, posta in un piccolo centro in Israele, alla base del Monte Carmelo. La moglie Ruta (insegnante di Bibbia) non lo accompagna, ma è perfettamente in grado di ricostruirne ogni passo, ogni mossa nell’andare, anche dopo che egli si è allontanato. Sola, torna con la mente a quegl’indimenticabili momenti trascorsi con lui e col loro figlioletto Neta, quando insieme scoprivano la meravigliosa natura del Paese. Ora quella gioia è passata: l’improvvisa morte del bambino pare aver allontanato per sempre i due genitori.
Sotto un enorme carrubo, a lui ben noto, all’interno di un wadi sul Monte Carmelo, Eitan aspetta adesso con pazienza qualcuno: non lo conosce direttamente; anzi, non lo ha mai visto prima, ma sa che è “lui” quello che, dopo qualche ora di attesa, sul far dell’alba, sta per arrivare. Ha capito di non aver sbagliato persona perché si è subito accorto che quel tizio è alla ricerca -concitata- di qualcosa. Nell’attimo in cui se lo trova di fronte, gli spara con lucida determinazione, non facendolo morire all’istante, però. Scopriamo, per quanto, al momento, solo in parte, il significato della scena iniziale della nostra storia. L’ucciso aveva assassinato, il giorno precedente, il nonno di Ruta, un uomo molto anziano, Zeev Taburi, figura centrale della vicenda. Conosciuto da tutti nel villaggio, questi era celebre per la sinistra benda nera che gli copriva un occhio divenuto cieco a seguito di un lontano incidente, cui peraltro nessuno aveva assistito. Molto facile ora, per la polizia, credere che il vecchio, dato l’incerto deambulare a causa dell’età, avesse inciampato, picchiando la testa su un sasso, e che fosse morto così. Ma pure il defunto, in anni remoti, allorché era giovane, forte e con una vista perfetta, aveva compiuto un duplice omicidio. La prima vittima era stato l’amante di Rut, sua moglie, il vero padre del bambino (o meglio, bambina) che ella aspettava e poi aveva messo al mondo; il secondo delitto era stato quanto di più ripugnante la mente umana possa concepire ed attuare.
“Due vendette”, pubblicato a inizio estate presso Bompiani, nella sapiente traduzione di Elena Loewenthal, è l’ultimo dono fatto ai lettori da Meir Shalev, uno tra i maggiori esponenti della letteratura israeliana: autore di libri per l’infanzia, di una raccolta di saggi e di vari romanzi, divenuti bestseller internazionali. Intriso di un fascino primigenio, come tutte le precedenti opere, questo testo tuttavia se ne distacca perché, in diversi momenti, ti fa precipitare nell’abisso di una violenza senza limiti, la stessa che riecheggia nelle tragedie greche, da saga degli Atridi.
Cuore della narrazione sono due vendette, lontane tra loro nel tempo -ma vicine nell’animo e nel sangue dei protagonisti-, scaturite da eventi terribili: l’una chiama l’altra in una spirale tragica all’apparenza inarrestabile.
In una tempestosa notte dell’autunno 1930 un giovane contadino, Nahum Natan -figlio di un illustre rabbino sefardita di Istanbul, Elihau Natan-, salito in Terra Promessa perché innamoratosi del sogno sionista, muore all’improvviso per un colpo d’arma da fuoco. Parrebbe trattarsi di un suicidio in piena regola; il terzo di quell’anno nel villaggio appena fondato dov’egli risiedeva. Tuttavia, contrariamente agli altri due casi, qui non siamo affatto di fronte ad un suicidio.
Peraltro tale versione è sia presa per buona dalla flemmatica polizia britannica, senza che vengano effettuati particolare accertamenti -alle autorità mandatarie poco interessano le beghe interne di un modesto centro della Palestina-, sia messa per iscritto nel telegramma inviato, dai responsabili del villaggio stesso, al padre di Nahum. Il povero genitore, disperato, si precipita a Haifa e di poi nel luogo dove aveva vissuto, per poco tempo, l’unico figlio.
Ad onor del vero, nella comunità, tutti sanno che cosa è accaduto sul serio e perché, ma nessuno parla chiaro; né lo farà nel seguito. Tutti assistono alla tragedia, anzi alle tragedie che avvengono sotto i loro occhi, senza intervenire; nessuno si ribella al male. Quell’immobile silenzio ne genererà, in seguito, un altro, ancora più truce. Sembra di essere in un paesino remoto della Sicilia, anziché in Terra di Israele, tra persone che avresti pensato animate da alti ideali e incapaci di commettere mostruose atrocità o esserne passivo testimone; e dunque complice.
Nondimeno il ricordo di ciò che avvenne allora è incancellabile. Tanto che adesso, a distanza di diversi decenni, quel fatto lontano (e quel che successe dopo) lascia affiorare ancora nelle coscienze un qual certo disagio, al punto che, come accade in simili frangenti, è meglio tacere in merito ad esso. Oppure soffermarsi su particolari, come la marca del fucile dal quale era partito il colpo fatale.
Ai giorni nostri tutta la storia è raccontata da Ruta (Rut), voce narrante del romanzo, una voce striata di malinconia, dolore, tenerezza, ironia, rabbia. La donna è, come detto, nipote, per parte di padre, di Zeev Taburi (il capostipite della famiglia), nonché protagonista femminile della nostra complessa vicenda.
Alla fine degli anni ’20 del Novecento, Zeev (“Lupo”), giovanotto pieno di energia e progetti, ma dal carattere ombroso, poco socievole, arriva in pianura dal sud della Galilea -vicino al Monte Tabor, dov’è originario- per partecipare alla costruzione di un nuovo villaggio, ai piedi del Carmelo. Poco dopo gli viene in aiuto il fratello maggiore Dov (“Orso”). Questi giunge guidando un carretto, trainato da un enorme toro. Sul carretto ci sono: una grande pietra in basalto nero -destinata ad essere incastonata nel muro della casa che Zeev va edificando, così da essere visibile sia dall’interno (“…perché sapessimo e sentissimo sempre chi siamo e da dove veniamo”), che dall’esterno (“perché tutti tenessero a mente con chi hanno a che fare”)-; inoltre, su detto carretto, pure destinati a Zeev, ci sono, nell’ordine: 1 fucile, 1 vacca, 1 albero (gelso) e 1 moglie.
L’ordine è seguito con scrupolo nell’esposizione fatta da Ruta a Varda Canetti, studiosa impegnata in una ricerca sulla storia degli Ebrei in Terra di Israele e, in particolare, sulle comunità agricole sorte (dalla seconda metà dell’800) sui fondi del Barone Rothschild. Il racconto, che dà vita al libro, si declina in quaranta capitoli, alcuni dei quali titolati. La prosa di Shalev adotta modalità espressive differenti, in grado di dare al romanzo una pluralità di affascinanti sfaccettature: il racconto a Varda, ad esempio, talvolta è in forma di dialogo tra le due donne, talvolta di esposizione nella quale l’interlocutrice si limita ad ascoltare e la voce narrante formula da sé domande e risposte. Non mancano, nell’intreccio, fiabe, dolci e sagge, scritte da Ruta per Neta, come quella dell’Uomo Primitivo che vive all’interno della grotta, tratte, in modo diretto o indiretto, dalla vita di nonno Zeev. O magari relazioni sulle vicende di famiglia rimaste allo stato di bozza.
Ad un certo punto facciamo la conoscenza di un’ immancabile figura, Angelomorte, la cui presenza sinistra aleggia su quella casa per anni e anni. Il tutto è arricchito dall’intrigante sapore del “giallo”. Passato e Presente si alternano di continuo, mettendo a dura prova il lettore, ma riuscendo ad incatenarlo alla storia, dalla prima all’ultima pagina; poiché la genialità del nostro scrittore sta nel fatto che la tenda del palcoscenico si apre pian piano sorprendendo ad ogni capoverso.
Perfetta la traduzione di Elena Loewenthal, a cominciare dalla capacità di rendere efficaci nella nostra lingua certi ironici, talora buffi, giochi di parole.
Ruta è giovane, affascinante, sensibile, ma brusca nel trattare coi suoi simili. Intercalari preferiti sono quegli spiazzanti “fa lo stesso” o “lasciamo stare”, coi quali spesso chiude le frasi; come per dire, a chi le sta di fronte, che -lei- non ha certo tempo da perdere col prossimo, sempre tardo a comprendere quanto va dicendo. Non tollera di essere contraddetta, è logorroica talora oltre i limiti dell’umana sopportazione; ma anche piuttosto riservata su vicende scabrose relative ai parenti. Suscettibilissima, basta poco a rendertela ostile! Ha un forte attaccamento alla famiglia -la sua-, anzi al clan, i Taburi, una sorta di animalesco senso del “territorio”. Nell’esprimersi, ha sempre quel tono febbrile, emozionato di chi porta su di sé il peso delle Tragedie di casa.
Per quanto sia arduo inserirsi nei suoi fitti soliloqui, Ruta dichiara di preferire lo scritto al parlato. La scrittura è un’attività che aveva iniziato in precedenza nel tempo libero, inventando favole per il figlio, i cui spunti attingeva da storie e leggende imparate da piccola. E poi la Storia ha una capacità di seduzione davvero particolare: “…è fatta di vicende umane” osserva “amori, nascite, morti, non di dispute ideologiche di stampo sionista sul ritorno alla terra o temi simili”. La vicenda qui narrata ben si attaglia a questi pensieri. Come sempre, non ne scrivo uno scontato riassunto, ma tento di catturarne alcuni filoni, procedendo, come direbbe David Grossman, con lo sguardo fino all’origine, ai Personaggi che le danno vita.
Subito Zeev e Nahum; all’inizio giovani amici, poi separati da un abisso di morte.
Due uomini assai diversi tra loro. Il primo: ombroso, vendicativo, con debolezze, in primo luogo psicologiche, in grado di emergere nei momenti più problematici della vita; amato dai nipoti, ma non dai figli, che se ne erano andati lontano, non appena ne avevano avuto la possibilità. Una famiglia, per usare un termine botanico, di tarassachi; essenze che fanno volare lontano i loro semi, alla ricerca di avventure e di posti migliori; contrariamente ai ciclamini, i quali fanno cadere i semi poco lontano da sé. Zeev è uomo crudele, ma riesce a “riscattarsi” dalle sue tremende colpe allevando i due nipoti, Dovik e Ruta, dopo che i loro genitori erano venuti meno: il padre, secondogenito di Zeev, era morto prematuramente, la madre aveva preferito l’America, lasciando al suocero i due ragazzi. Il legame instaurato con questi ultimi, il prendersi cura di loro aveva rappresentato per lui una sorta di riparazione di tutto il male compiuto. Ma il passato ritorna sempre; anche quando è si è un vecchio novantenne. Ma egli è pure capace di incredibili gesti d’amore nei confronti di persone non del suo sangue; come Eitan. Sarà proprio nonno Zeev a occuparsi del giovane, ormai a rischio di piombare in un baratro senza fine dopo la morte di Neta, praticandogli una versione dura ed insolita di ergoterapia (i Taburi sono proprietari di un vivaio). Inutile sottolineare che Zeev pratica una morale tutta sua, attribuisce, di propria iniziativa, a sé e agli altri, premi e, specialmente, castighi. E’ portatore di un’interpretazione del Decalogo che ben poco ha a che spartire con le comuni regole del vivere civile.
Il secondo, Nahum: sensibile e delicato, pelle chiara di chi non è avvezzo ai duri lavori manuali, è aduso ad indossare un paio di bellissimi stivali fatti confezionare per lui dal padre, quale dono, ad un abile calzolaio di Istanbul. Facile agli entusiasmi, subisce il fascino dei pionieri sionisti (e soprattutto delle belle pioniere, trecce bionde e occhi celesti), i quali, nel viaggio dall’Est Europa alla Terra d’Israele erano abituati a fare una breve sosta a Istanbul, in casa di Rav. Natan, che li accoglieva volentieri. Giovani e ragazze, infiammati da forti ideali, “elettrizzavano e rinfrescavano quell’aria immobile praticamente da secoli”. Nahum ne è coinvolto e s’imbarca fiducioso verso l’avventura. Qualche mese dopo il suo arrivo nella Terra dei Padri, va in un luogo alla base del Monte Carmelo, dove si sta costruendo un nuovo insediamento agricolo. Nella comunità appena formata egli suscita ammirazione incantando gli altri con danze e dolci melodie sefardite, ma pure una curiosa invidia perché viene percepito da loro come estraneo; troppo raffinato. Non è difficile immaginare come, nel prosieguo del tempo, egli perda la testa per una persona che sente affine: la moglie dell’amico Zeev, Rut, il cui rapporto col coniuge non ha mai conosciuto gioia fin dalla prima notte di nozze, nonostante i ripetuti sforzi di lei, per rimediare alla situazione; pur un po’ maldestri, complici la giovane età, l’inesperienza e….la mentalità dell’epoca. L’Autore dedica a Rut uno spazio minore rispetto a Zeev, ma sono sufficienti alcune pennellate per rendercela ben presente. L’umiliazione, il dolore, la felicità per aver incontrato qualcuno che sa starle accanto, il nuovo amore, sia pure clandestino, la paura del marito e il successivo tremendo odio nei confronti di lui. Come indimenticabili sono le immagini del rabbino Natan, giunto col cuore in pezzi, dopo la notizia della morte di Nahum, al villaggio. Il genitore, affacciatosi un attimo alla finestra della casa del figlio, vede subito una bella giovane donna incinta, cioè la stessa Rut, intenta, dal cortile accanto, a guardare nella sua direzione. “Gli occhi della donna fissarono un attimo quelli del rabbino, prima che lei si coprisse la bocca con la mano. Il rabbino la guardò tremando…” Che cosa comprende, o immagina, il visitatore, nel suo turbamento, anche se forse, non osa confessarselo?
E, in occasione di un veloce, successivo ritorno al villaggio, c’è un altro muto, ma intenso, incontro con lei, il cui volto “egli non aveva più dimenticato e che tante volte aveva visto in sogno”.
E Rut, che cerca, quando si ferma a osservare ossessivamente qualcuno che scava, ad esempio una fossa per irrigare una vigna? Quale dolore, quale ansia nasconde il suo silenzioso, ma tenace, vagare, che non si arresta nemmeno di fronte alla curiosità, mista ad irrisione, dei ragazzetti del paese, ignari della sua tragedia? Tragedia che la chiude in un mondo tutto suo, lontana per sempre dai familiari, perfino dai due figli che poi concepirà, senza alcuna passione, con il marito; sepolta in una sorta di sonno eterno, preludio alla morte sopraggiunta anzitempo.
Altra figura intensa è Eitan, marito di Ruta. Costei, pur amandolo, non riesce a fare a meno di ironizzare sul suo comportamento: “La gente era attratta da lui come le falene dal fuoco; ma a differenza dei poveri insetti, col suo fuoco gentile non si è mai scottato nessuno”. Eitan è invece persona affascinante, in grado di catturare ben presto l’attenzione del prossimo. Andatevi a leggere che cosa combina in occasione di un certo matrimonio….Ruta, allorché si riferisce a lui, è solita parlare di “primo marito” e “secondo marito”. Il primo è l’uomo che, per anni, ha amato, col quale ha condiviso l’esistenza; il secondo è quello dal quale, a seguito della morte del figlioletto, ogni anelito di vita sembra scomparso: la pelle gli si sbianca e diviene opaca, è irriconoscibile, non comunica con la moglie. Gli viene in aiuto Zeev: gli irroga, per la colpevole distrazione nei confronti del bambino, una lunga pena, molto dura, che tuttavia lo salverà.
Poi c’è Neta, l’adorato figlio. Sei anni, così equilibrato, armonioso, amatissimo, deceduto in modo banale per il morso di una vipera durante un’escursione nel deserto insieme col padre; pagine che grondano dolore, disperazione, senso di colpa, in Eitan, in primo luogo, ma anche in Ruta, allontanando i due. Il ragazzino è sempre presente nel libro e ci emozioniamo pensando a lui attraverso le parole della mamma e l’angoscia muta del papà. La sua morte rappresenta il perno centrale del romanzo, una sorta di contrappasso per le tragedie consumatesi, tanti anni prima, all’interno di una famiglia che sembra maledetta.
Infine una miriade di personaggi minori, che il lettore incontra man mano che procede lungo il cammino e che gli restano nella memoria.
La Natura tutta è, a sua volta, un personaggio del romanzo, partecipe degli eventi. La prima tragedia si consuma “sotto la prima pioggia dell’anno”, nel corso di un violentissimo temporale; come bene ci illustra, del resto, l’immagine riprodotta in copertina sull’edizione italiana “I tuoni e i fulmini che spaccavano il buio, le sferzate della pioggia, i lamenti, il pianto e lo sparo, tutto divenne un unico frastuono”.
E che dire del Deserto, incantato luogo dell’anima, così vicino alla sensibilità ebraica, dove Eitan e Neta si meravigliano di ogni scoperta: “Vieni, io guido fino in cima a quella collina lassù e tu [cioè Neta] al ritorno”? Ma al ritorno li attende un destino imprevedibile e feroce.
Alberi. Alberi autentici, in carne ed ossa li diresti, non gli assurdi bonsai, ai quali viene impedito di crescere da parte di certi “Mengele della botanica”. Alberi amati da Zeev: il Carrubo, dove egli portava in gita i nipoti per spiegar loro le bellezze della natura e accanto al quale muore; il Gelso, parte integrante della sua vita, fin da quando era bambino. L’Acacia, cui Eitan è molto legato: vicino ad essa si accampa con Neta la sera prima dell’evento fatale. poco lontano di lì accadrà la Disgrazia.
Gli Animali. Soprattutto le Cornacchie: Prima di questa lettura avevo idee assai approssimative su di loro: volatili un po’ petulanti, dal verso sgradevole. Nulla a che spartire con Regina Aquila o con i miei amatissimi, imperscrutabili Rapaci Notturni. Ma Meir Shalev , cantore dell’Israele più affascinante -quello naturale-, mi ha fatto conoscere aspetti sorprendenti di questi uccelli, che invito a scoprire attraverso alcuni significativi episodi.
In primo luogo la loro tragica partecipazione alla vita degli uomini, a somiglianza del coro nelle tragedie greche: “Ma entrambe [le cornacchie], quelle cinesi e quelle israeliane, sono brave a fare le imitazioni, e il pianto dei neonati è uguale nei due Paesi…”
Gli Oggetti sono quasi personificati. Si tratti di una pietra in basalto nero, della benda per un occhio cieco, di un bastone; o di un paio di stivali, “fedeli servitori che non vedono nulla, ma sanno tutto” e che vantano una lunga storia da raccontare, ricca di sentimenti più vari: il profondo amore di un padre; la trepida passione di due giovani amanti; la pazza gelosia impastata con la rabbia e con l’odio di un coniuge tradito; o il calcolato cinismo da falso amico, in grado di approfittare subito di una tragedia per trarre concreti vantaggi per sé. E un vecchio magazzino, quali segreti custodisce? Pare contento, confessa l’Autore, che qualcuno lo mandi in pezzi; quasi “ne avesse abbastanza di quel che conteneva” e non solo….Dentro una grande cassa di legno non ci sono monete d’oro o armi, ma un cuscino ricamato pieno di polvere del tempo e delle vicende umane. Tempo che tutto divora.
L’intero romanzo è ricco di Simboli Biblici. Ce ne parla Ruta, insegnante della materia. Dall’accostamento tra il viaggio verso il Monte Moriah di Abramo e Isacco, dal quale padre e figlio ritornano entrambi vivi, e quello nel Neghev di Eitan e Neta, che si concluderà con la morte del ragazzino. Alla riflessione che, a proposito della vipera, sorge spontanea: là, nel deserto, non c’era il serpente in bronzo di Mosè cui Neta, vittima del venefico morso, potesse guardare per essere miracolosamente guarito (v. Numeri 21, 8-9). Al titolo originale del nostro romanzo: “Two She-Bears”, cioè “Due Orse”. Nel dolore per l’assurda morte del figlio, Ruta si chiede, con disperato sarcasmo, perché mai D-o si sia accanito su di lui in un modo così “antiquato”. Uno stupido, arcaico, serpente. Che cosa Egli avrà ora in serbo per lei, madre a pezzi, nel suo armamentario? Quale assurdità? Magari lasciarla in balia di quelle due orse che, come si legge in 2 Re 2, 24, escono dal bosco e sbranano 42 ragazzi (in realtà giovinastri) colpevoli di aver ridicolizzato il profeta Eliseo perché calvo! All’immagine di nonno Zeev, essenziale per conoscerne il carattere (la luce e il terrificante buio), come uomo di territorio, di confini, definizioni e dichiarazioni di proprietà -caratteristica ereditata da sua nipote, del resto-: simile a Caleb, figlio di Iefunne (di cui a Giosuè, 14,11): “La mia forza allora è come la mia forza oggi, per uscire ed entrare”.
Per concludere, una lettura in grado di commuoverti, turbarti nel profondo, fino alle ultime pagine, un libro che ti diventa difficile lasciare. Inevitabile riprenderlo.
E quando penseresti che tutto ormai sia placato e concluso, che la terribile spirale di dolore abbia smesso di girare su se stessa, ecco l’ultimo colpo di scena.
Ma sarà proprio quell’atroce scoperta a portare finalmente la pace nell’anima e nella vita dei tormentati protagonisti.
(Titolo originale Two She-Bears, 2013 by Am Oved Publishers Ltd, Tel Aviv)
Trad. Elena Loewenthal, Ed. Bompiani / RCS Libri S.p.A. (collana Narratori Stranieri), Milano, Giugno 2014, pp. 403, €. 19,00
0 commenti
Inserisci un commento
*Per inserire un commento devi specificare il tuo nome e cognome ed il testo del commento.
Non e' possibile inserire link a siti web o indirizzi e-mail. Qualsiasi tag HTML verra' rimosso dal sistema. Qualsiasi termine ritenuto non adatto rendera' impossibile l'invio del commento.